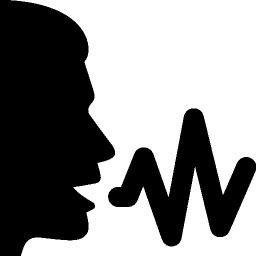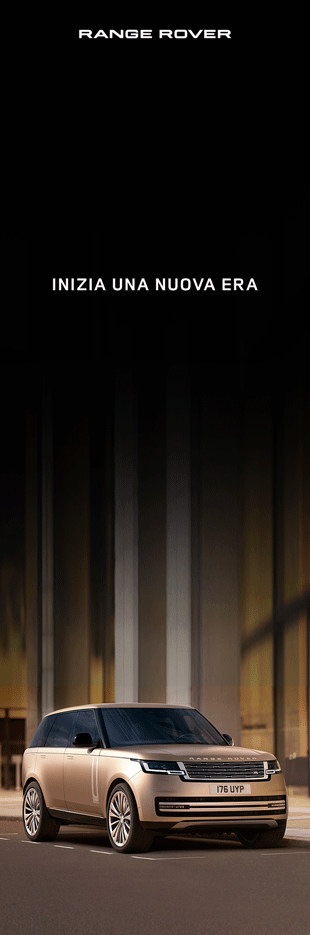Provando a raccontare le storie delle nostre migrazioni si corre il rischio di perdersi. Tante le facce, le storie e le modalità con cui, in questo Paese che ha per lungo tempo vissuto con le valigie in mano (e in fondo continua a farlo, considerando che ancora oggi il saldo migratorio è negativo), due milioni e mezzo di piemontesi se ne sono andati tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento. Il Museo Regionale dell’Emigrazione Piemontese nel Mondo dal 2006 cerca di riannodare quel filo, valorizzando uno scrigno di memorie e ripercorrendo quei sentieri interrotti che, proprio di questi tempi, riemergono dalla foschia dopo decenni grazie alle tante domande che arrivano agli uffici del nostro territorio dall’America Latina a causa, forse, delle nuove povertà post Covid. Anche se, dice Carlotta Colombatto, torinese, un dottorato in antropologia e un master in museologia, che riveste il ruolo di curatrice del museo dal 2016 ed è il braccio operativo del comitato di gestione della struttura presieduto da Elvi Rossi, «quando pensiamo ai nostri avi dobbiamo uscire da una visione pauperistica, da un’idea di povertà assoluta e miseria».
Dottoressa Colombatto, quindi il modello del contadino disperato che si imbarca non è corretto?
«Non del tutto. Naturalmente erano molti i casi come questi, ma fondamentalmente noi italiani siamo sempre stati, e rimaniamo, dei migranti economici: in generale, cercavano migliori condizioni di lavoro pur non essendo del tutto alla fame, spinti dalle crisi ricorrenti del nostro Paese. È storicamente importante quindi smentire questo cliché dell’italiano povero, perché sono partite persone di tutte le classi sociali, di ogni età e genere. Erano molti i professionisti affermati, da quelli del campo della moda alle costruzioni fino alla ristorazione, che hanno esportato il nostro saper fare in giro per il mondo».
E dove andavano più frequentemente i piemontesi in questa fase?
«Intanto teniamo conto che il Piemonte, a cavallo tra i due secoli, fu la quarta regione per numero di migranti, insieme alla Lombardia, preceduta solo da Sicilia e Veneto. Come è facile immaginare, la maggior parte si dirigeva verso la Francia, in primis per una questione di vicinanza geografica. Non solo: proviamo a metterci nei panni di un uomo di fine Ottocento, senza le moderne tecnologie, che non conosce granché al di fuori del suo paesino. Chiaramente, in Francia un piemontese trovava una certa somiglianza linguistica con il suo dialetto (visto che l’italiano era molto poco parlato); e poi, dobbiamo pensare che le nostre montagne al confine erano sempre state una grande cerniera, un passaggio».
Altrettanto significativa, anche dal punto di vista dell’immaginario odierno, è stata l’emigrazione verso l’America Latina e in particolare l’Argentina. Come si sceglieva di andare in un posto così remoto?
«La chiave era il passaparola, l’avere già parenti o amici in quei luoghi a cui ricongiungersi. Migrare, sembra banale dirlo, non è facile: è un grande salto nel buio. Quando si partiva spesso non si avevano certezze lavorative e poter già disporre di un appoggio in quel luogo era molto importante. Da qui nascono le intere comunità di piemontesi in paesi dell’America del Sud, un po’ sul modello di una Little Italy in salsa latina, a cui capitava che dessero anche il nome: pensiamo alle città di Silvio Pellico in Argentina o Osasco in Brasile di chiara derivazione piemontese. Un altro elemento importante era sicuramente legato al fatto che al Nord si partisse da Genova, che storicamente aveva rapporti commerciali e rotte già tracciate con quei luoghi. Fu un fenomeno davvero imponente, oggi per noi quasi inimmaginabile, tanto da far dire allo storico Fernando Devoto, uno dei massimi esperti della questione, che “in Argentina quasi tutto sembra italiano”».
Dottoressa Colombatto, la sua vita professionale si lega ormai da anni alle vicende di queste persone e queste comunità di migranti. La storia che l’ha colpita di più?
«Guardi, ho davanti a me propria ora un quadro di Beppo Levi, matematico torinese di origine ebraica. Docente all’Università di Bologna, era, già negli anni ‘20, un europeista convinto, un intellettuale che fu costretto a scappare in Argentina dalle leggi razziali, dove poi morì. La sua storia mi sembra importante per due ragioni: la prima per raccontare quanto la tipologia di persone che migrarono fosse variegata, ben al di là dei ceti più umili; la seconda, invece, tocca un aspetto decisivo a proposito del capitale umano delle migrazioni: quando si pensa alla mobilità delle persone raramente viene in mente la straordinaria ricchezza professionale, culturale ed esistenziale che queste possono portare nel luogo che raggiungono».









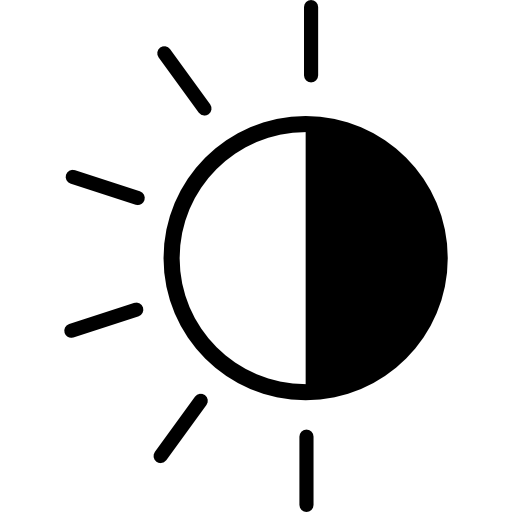 |
|
 |
|