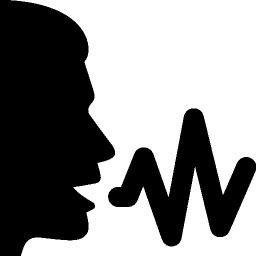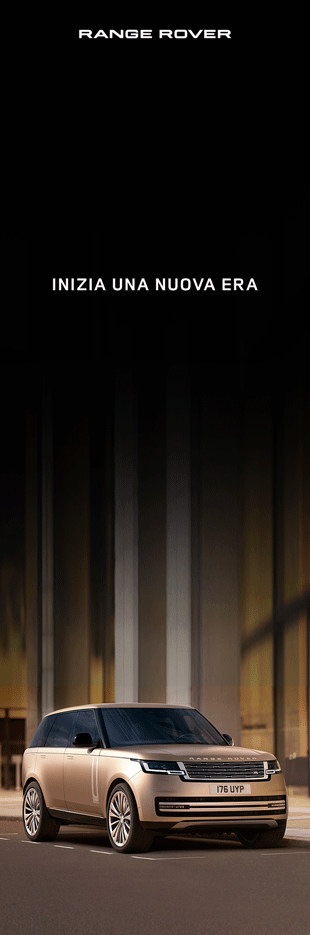Sulla sua parte ne “Il partigiano Johnny”, il film del 2000 diretto da Guido Chiesa dal romanzo di Beppe Fenoglio, Michele Di Mauro minimizza. «Una piccolissima parte, occasionale. Poi è il mestiere che ti invita a essere qualcuno anche quando non lo sei». Genuino, probabilmente modesto e comunque animato da un sano rapporto con la professione, magari anche un po’ condizionato da quell’understatement tutto torinese che lui, nato a Torino da madre pugliese e padre campano, ha evidentemente fatto proprio, Di Mauro è attore a tutto tondo, diviso da sempre tra teatro, cinema e televisione.
Proprio in tv lo si può vedere nella serie attualmente in onda su Rai 1, “Studio Battaglia”, dove interpreta l’imprenditore Roberto Parmegiani, ma anche qui non si scompone. «Un ottimo prodotto, le prime puntate hanno raggiunto il 20% di share, il che significa che circa cinque milioni di italiani lo guardano. Ma il mio personaggio è secondario, vive attraverso una narrazione orizzontale. Resta il fatto che se ci sono è perché mi hanno scelto e quindi ci sono almeno altri dieci attori che lamentano di non essere stati scelti».
Parliamo invece del film che sta girando a Torino, questa volta come protagonista.
«Si intitola “Non morirò di fame”, il regista è Umberto Spinazzola, lo stesso di Masterchef e questo film è anche figlio di quel lavoro. È la storia di un ex chef che scappa da Torino dopo aver dato fuoco al suo ristorante che aveva perso la stella Michelin e si ritrova a vivere come un derelitto».
Ma non finisce qui.
«No, finisce che ritorna per motivi di famiglia e incontra un barbone che in realtà è stato un conte e un falsario finito in disgrazia interpretato da Jerzy Stuhr, l’attore polacco che ha fatto, tra l’altro, “Film bianco” di Kieślowski. Con il loro incontro il film prende una piega diversa».
E il cibo che ruolo ha?
«Il cibo è al centro del film nel senso che si parla di ecosostenibilità, di scarti alimentari e di recupero di materie prime povere».
Invece qual è il suo personale rapporto con il cibo e la cucina?
«Ottimo. Mi piace mangiare e spadello volentieri. Inoltre per girare questo film ho preso lezioni da uno chef torinese e ho imparato a fare una serie di cose a regola d’arte, tipo tagliare le verdure, disossare una coscia di pollo».
Il suo piatto preferito, magari in un tour gastronomico nelle Langhe?
«I ravioli al plin con un bicchiere di Pelaverga, un monovitigno che c’è solo a Verduno. E in genere non resisto alla cotoletta impanata. Ma in questo periodo sono a dieta ferrea perché ad aprile devo girare un film dove devo essere magro».
Di che si tratta?
«Della versione italiana della serie francese “God my agent”, che racconta i capricci delle star del cinema attraverso il loro agente, che interpreterò io. Andrà in onda su Sky e il regista è Luca Ribuoli. Al centro del plot c’è una star, appunto, che interpreta se stessa».
Ci anticipa qualche nome?
«Non posso dire ancora niente ma può immaginare. In Francia i nomi sono stati Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Christopher Lambert, Jean Reno».
Dunque faccio un’ipotesi: Paolo Sorrentino? Toni Servillo?
«Io non le ho detto niente».
Le è piaciuto “È stata la mano di Dio”?
«Mi è piaciuto molto fino a tre quarti poi ho l’impressione che cali un po’. Ma è tornato a essere scritto molto bene da Sorrentino stesso e anche Toni Servillo che a volte “servilleggia” un po’ troppo, qui è completamente al servizio del film e del personaggio».
Lei è anche doppiatore, cosa pensa del doppiaggio “a tavolino”, cioè affidato a voci esercitate a doppiare ma non necessariamente opera di attori?
«Io non concepisco il doppiaggio se non come il lavoro di un attore, ma è vero, pare che esista il doppiaggio a tavolino e il rischio è quello di scadere in stereotipi».
Quanto è importante che il timbro si avvicini a quello originale?
«Raramente ci si incolla se il timbro è completamente diverso ma ci sono anche casi che smentiscono questo e altri invece in cui si sacrifica la credibilità per scegliere nomi importanti, magari attori bravissimi ma la cui voce non c’entra niente con quella dell’attore doppiato».
Veniamo al teatro che la riguarda come attore, regista e anche insegnante. Lo spettacolo “Le sedie di Ionesco” con la regia di Valerio Binasco sta riscuotendo un grande successo. Qual è il suo rapporto col pubblico?
«Il rapporto col pubblico è fondamentale, assoluto. Quel momento irrinunciabile di comunione alla base dello spettacolo dal vivo esiste solo in presenza del pubblico. E anche il mio impegno come insegnante non è solo rivolto a formare attori ma un nuovo pubblico, spettatori attenti, informati. La dimensione di laboratorio per me serve anche a questo. Inoltre le scuole in Italia sfornano un migliaio di diplomati ogni anno e il bacino di richiesta è invece molto basso».
Tornando a “Le sedie”, è impressionante che si parli di distruzione di città in uno scenario che sa di apocalissi.
«Infatti. “Le sedie” è una commedia scritta nel 1952, poco dopo la fine della guerra, però oggi, purtroppo, è attualissima».










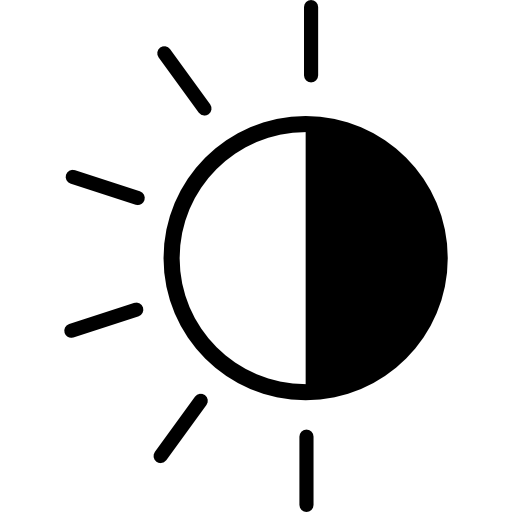 |
|
 |
|