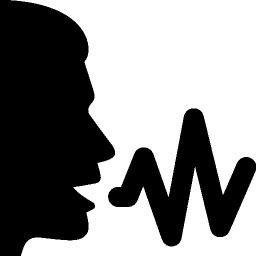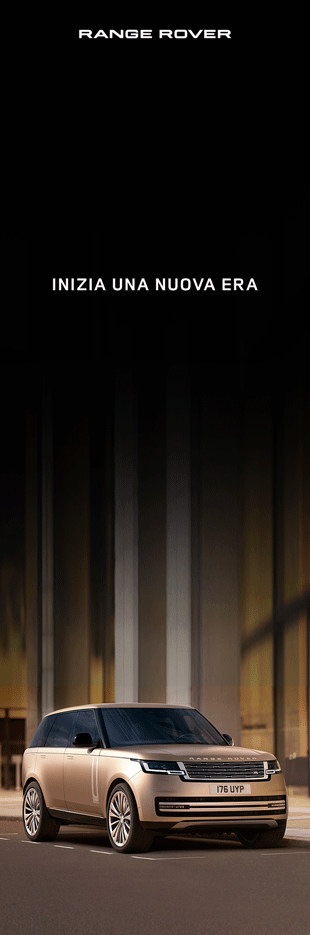“Ci sono due fari nel mondo della chitarra: uno è Django e l’altro Fausto Mesolella”. Così si esprimeva Piji, al secolo Pierluigi Siciliani, in un post del 2015, appena sceso dal palco del Premio Umberto Bindi a Santa Margherita Ligure, dopo avere omaggiato Pino Daniele accompagnato dalla chitarra di Fausto Mesolella.
Fausto è stato il chitarrista storico degli Avion Travel, scomparso quattro anni fa, lasciando nel mondo della musica un grande vuoto, pieno soltanto di nostalgia e tristezza. Al punto che nel primo concerto degli Avion post Mesolella, la chitarra non c’era. Django invece è Django Reinhardt, chitarrista jazz di adozione francese a cui Woody Allen ha dedicato “Accordi e disaccordi”, il film con Sean Penn in stato di grazia.
E Piji omaggia Django proprio a partire dal personaggio inventato da Woody Allen, tale Emmet Ray ossessionato, stringi stringi, dal non essere Django e che ora dà il nome alla sua orchestra.
Parliamo quindi della Emmet Ray Manouche 4et, l’orchestra che ha fondato qualche anno fa, composta da cinque chitarre, compresa la sua, due contrabbassi e un clarinetto. Come può definirsi la vostra musica?
«A me piace fondere la musica swing e la canzone d’autore, ma lo swing anni Trenta, lontanissimo dalla musica elettronica così come la canzone d’autore è lontana dall’improvvisazione jazzistica».
Una musica di nicchia, mi pare. Come conquistate il vostro pubblico?
«Il pubblico è una creatura strana. Manca la curiosità per le novità, per le cose che non si conoscono, ma quando lo coinvolgi, magari per caso, allora risponde. A volte mi capita di cantare in concerti non miei, e di fronte a un pubblico da conquistare, imbuco due canzoni di Django».
E dunque veniamo a Django: questo chitarrista che suonava con la mano sinistra menomata, a causa di un incendio, e che ha inventato una tecnica nuova, rivoluzionaria.
«Django, come Fausto, sono stati entrambi inventori di un modo nuovo di suonare la chitarra, ma credo ce l’avessero dentro. E che l’incidente, per Django, abbia solo incoraggiato la ricerca e l’espressione del suo estro. Il suo lavoro è stato fondere due mondi lontanissimi come il jazz colto americano e la musica zingara francese, popolare, ritmica, calda, e creare un terzo genere, che non ha uguali: il jazz manouche».
Con la Emmet Ray Manouche 4et siete stati orchestra residente a Edicola Fiore, il format condotto da Fiorello per un bel po’ di anni. Che esperienza è stata?
«Bellissima. Io sono nottambulo, ma in quel caso mi alzavo alle 4.30 per andare in onda all’alba. Ripagato dal fatto che Fiorello è una forza della natura tale da farti passare il sonno e i dolori allo stomaco. Il suo intervento è taumaturgico. E tra una battuta e l’altra si snocciolavano tematiche importanti di attualità. Edicola Fiore ha vinto il premio “È giornalismo”».
Possiamo avere un’anticipazione del concerto prossimo del 13 agosto in un posto bellissimo come il Parco Avventura di Fregene?
«Sicuramente ci saranno brani dello stesso Django e altri di repertorio gypsy jazz con alcuni intermezzi cantati, compresa la musica italiana con versioni curiose di pop in chiave manouche».
Quali?
« “C’è che dice no” di Vasco, una versione che lui stesso ha apprezzato e postato sui suoi canali social; “L’estate sta finendo” dei Righeira, in modalità lenta, quasi drammatica, perché le parole, nonostante sembri uno scherzo, sono di amore drammatico. E poi “Ballo ballo” di Raffaella Carrà: anche questo un brano che amo molto e che ho riproposto in modo da dare a una canzone apparentemente frivola un piglio drammatico, una dimensione interiore che emerge solo cambiando degli stilemi. Eseguita a tango infatti prende una piega molto passionale».
Una canzone, quest’ultima, che assume ora un significato particolare, una sorta di omaggio a Raffaella.
«Certamente. Anche se “Ballo ballo” è una canzone che avevo già inserito nella colonna sonora di “Non si uccidono così anche i cavalli”, lo spettacolo diretto da Giancarlo Fares che ha debuttato al Festival Teatrale di Borgio Verezzi nel 2018. Una colonna tutta pensata su musiche dedicate al ballo e rivisitate in chiave jazz, rock, blues, swing, tango, elettroswing».
Uno spettacolo dove lei era anche in scena.
«Sì, come musicista, anzi, nella parte del musicista».
Dunque un attore che suonando interpreta un musicista?
«Esattamente. La mia nascita è nella contaminazione di teatro e musica. Il mio pallino è da sempre il teatro canzone. Quello di Giorgio Gaber, soprattutto. Quando ero piccolo mi sono fatto regalare una chitarra con la spalla mancante, uguale a quella di Gaber».
Qual è il primo disco che ha acquistato?
«Un 45 giri di Gaber, appunto. Erano gli anni Novanta, i vinili erano spariti e io cercavo nei mercatini la musica degli anni Sessanta. Sempre di Gaber ho acquistato un 33 giri da regalare a mia sorella e poi mi sono registrato la cassetta. Avevo 13 anni».
E poi?
«Poi ho studiato il jazz, seriamente. E amo quella linea che sconfina nello swing».
Dovesse spiegare a un profano cos’è il jazz manouche cosa direbbe?
«Mah, forse di ascoltarlo. È una musica molto difficile da suonare ma facile da ascoltare, calda, cantabile».
Perché è difficile da suonare?
«È la summa di quello che nel jazz è l’improvvisazione strutturale. Bisogna stare dentro ranghi molto stretti, una griglia ferrea entro la quale muoversi con estro e bellezza».
Il suo regista preferito?
«Woody Allen. Nel mio cuore può competere solo con Gaber. Woody Allen ha rilanciato alla grande il jazz manouche anche grazie al suo film».
Nel suo spettacolo sarà presente la “voce” di Woody?
«Inserisco tra un brano e l’altro alcuni testi che più mi avvicinano alla sua poetica, ma la cosa più importante sarà la musica».
Nel suo curriculum c’è anche la radio, qual è il suo rapporto con questo mezzo?
«La adoro. Sono due anni che ne sono lontano e mi manca. La radio è un mezzo bellissimo per raccontare la parola, si basa sul costrutto, sulla sintassi e presuppone una grande attenzione alla lingua in genere».
A proposito di parola, che libro ha sul comodino?
«“Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce”. Riguarda il primo esempio di calcio femminile in epoca fascista quando le ragazze erano vessate da proibizioni, prese in giro, pregiudizi e anche insulti, che poi sono gli stessi di oggi».
Volevo arrivare qui: parliamo di “No wags : il calcio (non) è uno sport per signorine”, lo spettacolo di cui è regista che debutterà sabato 24 luglio nel cartellone romano de I solisti del Teatro.
«È uno spettacolo di monologhi, stand up e musica messo in piedi con un collettivo di attrici che racconta il calcio dal punto di vista femminile. Il sottotitolo riprende la famosa frase di Guido Ara, calciatore dei primi del Novecento, che purtroppo non è così inattuale. Wags sta per wife and girls, mogli e fidanzate dei calciatori».
Come le è venuta l’idea?
«È che quando una cosa non mi piace sento l’esigenza di indagarla. Pensi che a tutt’oggi le squadre femminili non sono ancora considerate professioniste, non hanno indennità e non hanno diritto alla maternità e alle ferie. Ora si sta muovendo qualcosa, ma mentre negli altri settori della vita la lotta alla parità è avviata da un pezzo, con il calcio siamo rimasti all’età della pietra».
Articolo a cura di Alessandra Bernocco










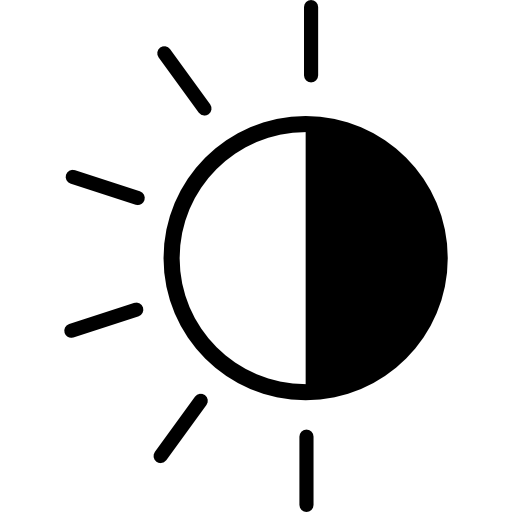 |
|
 |
|