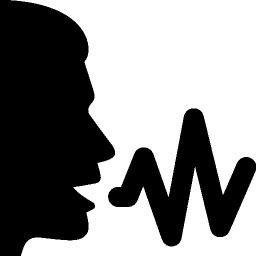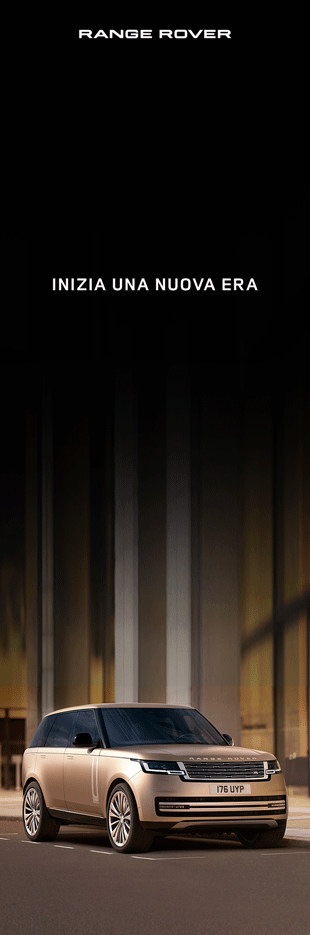I cinefili hanno appena avuto modo di apprezzarlo in un film duro e impegnativo, “Freaks Out”, uno spaccato crudo e surreale della Seconda Guerra Mondiale, scritto e diretto da Gabriele Mainetti, abitato da guitti con poteri paranormali, da mostruosi avanzi di una comunità in fin di vita, da rottamati indifesi ma disposti a tutto pur di difendere la causa partigiana contro gli occupanti nazisti perché “la guerra è guerra”, come dice il Gobbo alla ragazza elettrica. Il Gobbo è lui, Max Mazzotta, che da questo film ha riscosso un bel successo anche personale.
Chi è questo Gobbo disposto a tutto e come si rapporta con i supereroi?
«I freaks sono super, ma non sono eroi perché non sono consapevoli del loro potere, mentre il Gobbo fa parte degli umani, diversi a causa di un handicap a cui sopperiscono con il coraggio. Il loro superpotere è il coraggio, l’umanità. Il mio personaggio è folle, sopra le righe, ma è umano».
Un personaggio che ha incontrato i favori del pubblico.
«Credo che il pubblico abbia percepito l’alchimia che c’era tra noi e con il regista. C’era apertura reciproca a possibilità nuove, assenza di pregiudizi, una naturalezza infantile. Mainetti è un regista visionario con cui c’è stata una sintonia immediata, ci conosciamo da dieci anni e c’è tra noi una stima reciproca».
Da chi è venuta l’idea di fare parlare il suo personaggio con l’accento cosentino? E la parola “pisciaturo” da dove arriva?
«È un’espressione bruttissima ma efficace. La scelta del dialetto è stata naturale, io sono cosentino e noi usiamo queste metafore sporche, dure. Come i napoletani, d’altra parte, che però sono più sofisticati. Noi siamo più grezzi, ma non meno poetici».
Lei è cosentino ma arriva dal Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, non proprio una cantina.
«Eh sì. Ho avuto grandi insegnanti».
E ha lavorato in spettacoli storici. Brecht, Pirandello, Goldoni, Moliere, Goethe. Ce lo regala un ricordo?
«Proprio a proposito del dialetto cosentino, le racconto una cosa. Facevamo l’Arlecchino e io interpretavo il capocameriere. Alle prove Strehler mi chiese “di dove sei?” e poi volle che lo facessi con il mio dialetto calabrese, che non ha mai avuto tanta fortuna dal punto di vista nazionale. Si divertì moltissimo. Aveva un amore sviscerato per il gioco del teatro».
Per questo poi fece persino Amleto in versione calabrese?
Quello è un mio spettacolo successivo ai tempi del Piccolo. Un Amleto in versione commedia dell’arte ispirato alla nostra maschera di Giangurgolo, un capitano spagnolo che fa il verso a Falstaff e racconta palle come un mitomane. Ho seguito le dritte di Ferruccio Soleri, mio maestro al Piccolo, per dare dignità a questa maschera poco conosciuta».
Al cinema ha lavorato con registi come Marco Risi, Mimmo Calopresti, Renato De Maria, di cui ricordo, in particolare, Paz, ispirato ai fumetti di Andrea Pazienza.
«Un film rivoluzionario, il primo film girato in digitale, un’esperienza coraggiosa che mi ha permesso di approfondire il mondo di Andrea Pazienza, una figura che ha rappresentato un’evoluzione dal punto di vista del disegno fumettistico, che è pittura e consapevolezza umana».
E partendo di qui ha poi girato il suo primo film da regista, sorta di prosieguo o spin-off di Paz, Fiabeschi torna a casa. Chi è Fiabeschi per Max?
«Fiabeschi (l’eterno studente sgangherato, ndr) rappresenta un mondo chiuso, da cui non riesce a uscire, intrappolato dai suoi vizi e incapace di andare oltre. Una specie di larva che non diventa mai farfalla. Ma Pazienza lo ha messo lì come monito per dire “attenzione!”. Una specie di Pinocchio che deve crescere».
Come spettatore invece su cosa si orienta?
«Non sono proprio uno spettatore modello. Sono molto curioso, ma se poi lo spettacolo non mi soddisfa o non mi piace sto male. Se lo spettacolo mi piace, sto male lo stesso, perché vorrei salire sul palcoscenico anche io. Se lo spettacolo è “così così” non riesco a stare fermo, a stare tranquillo. Andare a teatro non è come andare al cinema. Al cinema riesco a stare più tranquillo, mentre a teatro vado avanti con il pensiero, intuisco qualcosa che deve accadere dopo. Sono uno spettatore molto viziato e quindi per me vedere uno spettacolo è sempre un’esperienza “difficile”, però è chiaro che mi diverto! Questo è, ovviamente, il mio modo di essere, però mi diverto».
Che musica ascolta?
«Dipende dai momenti. Ci sono periodi in cui ascolto musica classica, periodi in cui ascolto musica elettronica, periodi in cui voglio cantare a squarciagola, e allora ascolto Lucio Battisti, che mi dà la possibilità di esprimermi vocalmente. A volte ascolto il pop, a volte ascolto cantautorato moderno, non c’è un genere in particolare che mi affascina più di altri».
Che consigli darebbe a un giovane che vuole fare l’attore?
«L’unico consiglio che posso dare è di non “fare” l’attore, ma di “essere” attore».
Pare facile. Qual è allora la differenza?
«Fare l’attore è come indossare un costume. Essere attore è invece togliersi qualsiasi straccio, però poi alla fine il mondo è sempre un movimento degli opposti; per cui, forse, il migliore attore è quello che si veste e si sveste di continuo. Rimanendo sempre e comunque senza scarpe».
Qual è il suo prossimo impegno a teatro?
«Ho appena ripreso uno spettacolo che ha debuttato la scorsa estate al Campania Teatro Festival. Si intitola “Vite di Ginius” ed è il racconto di un’anima che ricorda quattro vite passate attraverso gli incontri che l’hanno segnata. Si percorre un arco di tempo che va dal 1.800 al 2.800 e si immagina un’epoca in cui il potere della mente e dell’intelligenza si afferma a scapito dello spirito».
Si tratta di un monologo?
«Sì, un monologo nato durante il lockdown, quindi in un momento di grande difficoltà per tutti, per gli attori che devono provare, e per il pubblico, naturalmente, a cui si chiede un forte atto di coraggio».
C’è differenza tra il pubblico al nord e al sud?
«Il pubblico prevede distinzioni socio-culturali anche in base al territorio d’appartenenza (soprattutto in Italia) ma l’opera non può risentire di nessun cambiamento, resta sempre fedele a se stessa».
E lei come si rapporta con il pubblico?
«Io con i miei spettacoli cerco di sollecitare domande, di offrire occasioni di pensiero. Non accetto l’idea che il nostro sia un mondo dove non c’è tempo di pensare. Bisogna anzi rinnovare il pensiero perduto perché non è vero che il pensiero non può esistere al tempo di Internet. Il pensiero è un po’ come il vino, cosa antichissima che ha un posto d’onore anche nel mondo contemporaneo».
Ecco, il vino. Il Piemonte è terra di vini e di buon cibo. Com’è il rapporto di un calabrese con il vino e con il cibo?
Da calabrese, appunto. Perché anche la Calabria è terra di buon cibo e di vino. Un bicchiere a tavola non manca mai».
Qual è il suo piatto preferito?
«Di fronte alla pasta fatta in casa da mia mamma con il sugo che solo lei sa fare, io mi riempio di immenso».










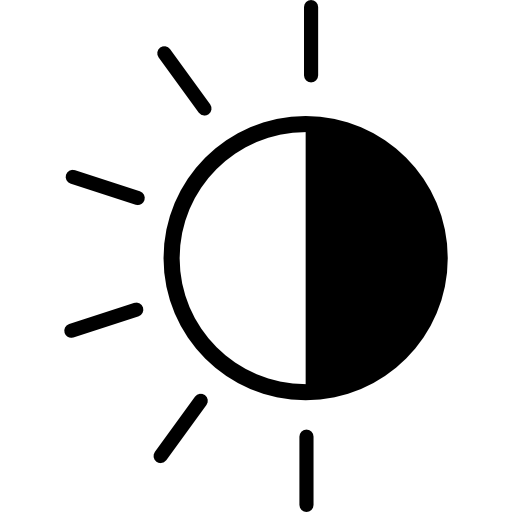 |
|
 |
|