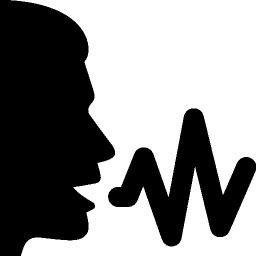«Vai in strada, prova a fermare uno a caso e chiedigli a cosa serve l’arte. Probabilmente riceverai un sorriso imbarazzato e nessuna risposta; perché, nell’epoca in cui tutto sembra avere un prezzo, anche l’arte è diventata una merce tra le merci. Ma forse questo incredibile periodo ci darà l’occasione di cambiare». Ugo Nespolo sembra capace di vedere oltre la china e di immaginare un futuro dopo l’anno dalle tinte apocalittiche che si sta concludendo. Certo, il suo mondo, quello dell’arte (e, più in generale, della cultura) oggi appare un campo pieno di macerie: azzerato dal virus, con poche speranze di una rapida ripresa e con un domani tutto da reinventare. Eppure Nespolo, artista di fama internazionale, scommette su un «effetto nostalgia che ci farà riscoprire qualcosa di tutto ciò che abbiamo perduto. Negli ultimi anni il sistema dell’arte si era espanso oltremisura, in maniera poco virtuosa: questa malattia ci ha tolto tante cose, ma di alcune potremo fare decisamente a meno». Non sono bastate le mostre delle sue opere esposte in tutto il mondo e una vita decisamente dal profilo “internazionale” per far perdere a Ugo Nespolo un certo pragmatismo tipicamente piemontese che smentisce, fin dalle prime battute, i triti stereotipi sugli artisti. Nato nel Biellese ed emerso a partire dagli anni ’60, Nespolo si avvicina alla Pop Art e al filone poverista (anche se risulta difficile incasellarlo in un genere), per poi esplodere definitivamente tra anni ’70 e ’80. E allora ecco il successo, il Premio Bolaffi nel 1974 e poi il periodo americano, passato a cercare di «portare l’arte nella vita» attraverso la vita stessa, raccontata dai marciapiedi e dalle strade di New York; fino alla consacrazione degli ultimi decenni, alle collaborazioni col cinema e col mondo della pubblicità.
Maestro, come recita il titolo del suo prossimo libro, sembra che lei abbia fatto di tutto “per non morire d’arte”.
«Indubbiamente non ho avuto una carriera lineare. Ho sempre lavorato in una prospettiva eclettica, cercando di muovermi tra discipline diverse. E poi la mia formazione è avvenuta nella Torino degli anni ’60, dove ho frequentato l’Accademia di belle arti, e quel mondo era vivo, pieno di energia. Lì sono venuto in contatto con filosofi come Gianni Vattimo e Luigi Pareyson e ho capito che la mia strada sarebbe stata l’arte. Anche se la mia famiglia mi voleva magistrato, pensi un po’ (ride, ndr)».
E che cosa ha fatto a quel punto?
«Tutto sommato, ciò che si fa anche adesso. Sono andato fuori, a Milano, a Roma, continuando a studiare e a conoscere forme artistiche diverse, senza però rimanere mai vincolato all’arte in senso stretto. E poi sono arrivate le esperienze negli States..».
Il suo lavoro ha assunto via via uno sguardo sempre più internazionale. Eppure in lei sembra permanere un legame profondo con la nostra terra, il Piemonte. Come vive, professionalmente e personalmente, il rapporto tra la realtà della provincia e gli orizzonti, ben più ampi, della sua carriera?
«Le racconto una storia. Anni fa ero in Argentina, a Buenos Aires, per una conferenza; organizzammo un incontro nell’interno del paese con alcuni vecchi piemontesi emigrati in Sud America, con cui si parlava solo in dialetto. Venne fuori, parlando, che molti di questi sentivano la mancanza della nebbia. Capisce? Ci sono alcune cose, delle sensazioni, dei colori dell’anima, che per quanto tu vada lontano non si possono cancellare. Io continuo a vivere a Torino e, nonostante il lavoro e le esperienze, qui ritrovo la mia dimensione».
A questo proposito, lei è stato recentemente dalle nostre parti, nel Cuneese, con la sua mostra alla Banca d’Alba.
«Una bellissima esperienza. Collaboro frequentemente con diverse realtà della provincia di Cuneo, dalla Fondazione Ferrero alla Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba fino al mondo delle etichette dei vini, dove ho realizzato alcune illustrazioni. Le dirò, c’è qualcosa in quelle zone, a livello umano e di carattere, che dovrebbe essere esportato».
Che cosa intende dire?
«Scrivevo tempo fa su un giornale che Torino dovrebbe cercare di essere una Cuneo in grande. Mi spiego: in quella terra c’è ancora una serietà, un modo concreto di guardare alla vita e di fare le cose che non posso che apprezzare. Si respira ancora un certo “rigore sabaudo”, una visione pratica capace di realizzare i progetti, a differenza, per esempio, di una Torino che oggi sembra essersi chiusa molto».
Diciamo anche che il periodo non aiuta. E l’universo della cultura sembra pagare più di tutti. Secondo lei, da questo punto di vista, si è perso definitivamente qualcosa in questo 2020?
«Difficile fare bilanci e previsioni adesso: è sotto l’occhio di tutti ciò che sta capitando al settore museale e alle mostre, e ci vorrà tempo per ripartire. Prima di questa crisi, come dicevo, anche per l’arte era passato il principio del “ciò che costa, vale”. Cercando il positivo nel negativo, questo momento di stasi ci può insegnare invece che c’è ancora bisogno di teoria, di tornare a pensare e interrogarci sul perché delle cose. Lo stesso vale per l’arte: dovremmo riuscire a fare vedere il significato e il valore della cultura al di là del denaro».
Una funzione sociale dell’arte, insomma?
«Intanto dovremmo capire cosa si intende con tale espressione. Se parliamo di un’arte impegnata, che critica la società e si pone come testimonianza di un’idea, indubbiamente questa attitudine al sociale è stata persa. Il nostro mondo iperconnesso ha generato una marmellata culturale, omologando anche il settore artistico: mi accorgevo già anni fa che da Pechino a New York è facile trovare opere simili, non perché quei mondi siano gli stessi, ma perché il mercato richiede prodotti uniformi. E così quel settore è diventato una sorta di “optional”, di cui tutto sommato ci si interessa poco».
I “social network” ci hanno abituato a una forma di comunicazione istantanea, in cui anche le immagini durano il tempo necessario per passare da un post all’altro, con il rischio di lasciare poco spazio alla riflessione…
«Certamente vediamo immagini ovunque e i nostri occhi, continuamente stimolati, perdono interesse per le cose che forse meriterebbero più attenzione. Con questo non voglio dire, naturalmente, che il mondo dell’arte debba fare a meno delle innovazioni; l’arte, infatti, deve sempre vivere il proprio tempo.
Lei ha un buon rapporto con la tecnologia?
«Assolutamente. La utilizzo, personalmente e professionalmente: come dicevo, credo che anche il nostro settore debba sfruttare le tante novità positive che questa rivoluzione ci ha portato».
Pandemia permettendo, quali saranno i prossimi artistici appuntamenti che la vedranno protagonista?
«Avevo in programma mostre a Madrid, Roma, in Cina e a Erevan, in Armenia, ma purtroppo, a causa del virus, per ora è tutto fermo. Attualmente mi sto dedicando alla scrittura del mio ultimo libro. Speriamo di ripartire nei prossimi mesi; nel frattempo, non resta che usare questa fase per riflettere su molte cose».









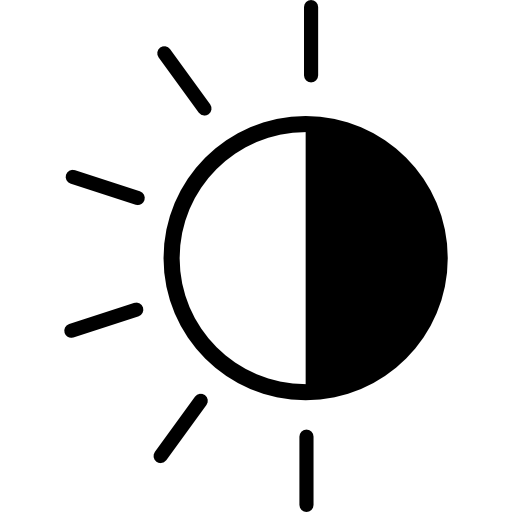 |
|
 |
|