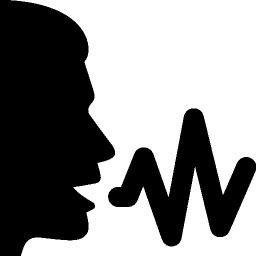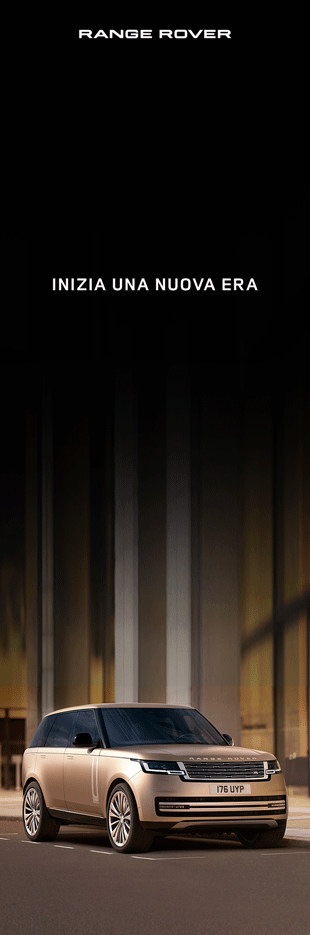Il “manicomio” è uno dei luoghi più oscuri e feroci dell’immaginario collettivo: sulla sottile linea che divide la cura dalla prigionia, è spesso immaginato come disumana appendice del sistema pubblico che fa dell’isolamento e dell’esclusione i propri strumenti. Eppure, fino alla chiusura avvenuta qualche decennio fa, gli istituti psichiatrici hanno costituito un tassello fondamentale del sistema sanitario nazionale e sono stati lo specchio di un mondo in rapido cambiamento, soprattuto riguardo alla percezione della malattia e della diversità.
Conoscerne la storia vuol dire fare i conti con chi eravamo e con chi siamo, per non dimenticare i costi del progresso, ma anche i suoi meriti.
Con il libro “Una casa di custodia per maniaci pericolosi-Storia del manicomio di Racconigi dalle origini al fascismo” (“Primalpe”, 2019) lo ha fatto lo storico Fabio Milazzo, classe 1979, ricercatore dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo, collaboratore della cattedra di storia contemporanea dell’Università di Messina e del Centro studi in psichiatria e scienze umane del Dipartimento di salute mentale dell’Asl Cn1 di Cuneo.
Milazzo ricostruisce i sessant’anni di storia di uno dei più importanti istituti della Granda.
Per conoscerne gli aspetti più interessanti abbiamo intervistato l’autore per i lettori di “IDEA”.
Partiamo dal titolo del libro, “Una casa di custodia per maniaci pericolosi”…
«E’ una citazione letterale della risposta che la Commissione amministrativa della Provincia, responsabile delle spese relative al manicomio, diede al direttore Enrico Toselli che si lamentava per le condizioni dell’istituto. La dialettica si inserisce in un più ampio dibattito tra le parti, proseguito negli anni, tra due visioni del manicomio: secondo il Direttore, l’istituto doveva essere “un’infermeria di cervelli ammalati” e non un asilo di sicurezza. Invece le autorità provinciali, per le quali il manicomio rappresentava la voce di spesa più rilevante tra quelle sostenute, gli ricordavano che, appunto, il manicomio non era, e non doveva essere, tanto “una casa di cura quanto una casa di custodia per i maniaci pericolosi”. Per inciso la differenza dei punti di vista, su cui ho insistito nel libro, mette in discussione, almeno secondo questi dati, una radicata lettura ideologica che negli anni ha individuato nel “potere psichiatrico” (come sostiene Michel Foucault) il principale agente delle disumane condizioni di vita degli internati nei manicomi».
Il manicomio di Racconigi venne fondato nel 1871, all’alba dell’unità nazionale. Qual era, all’epoca, la funzione di questi istituti e che condizioni c’erano, in particolare, nella struttura della provincia di Cuneo?
«La funzione di quegli istituti, pur con le differenze che ho indicato, era fondamentalmente quella di garantire la sicurezza sociale e di allontanare dalla società i “maniaci”, una delle designazioni più usate al tempo, che rappresentavano un pericolo o uno scandalo “per sé o per gli altri” (secondo la nota formula che sarebbe stata ripresa dalla legge che nel 1904 metteva ordine nella questione). Riguardo alle condizioni della struttura, è piuttosto rappresentativa la descrizione che il direttore Toselli fece nel 1875, per rendere l’idea del clima tra le mura dell’istituto: “Immaginate un individuo colpito da depressione
melanconica con delirio di persecuzione e idee di dannazione che, tratto o per inganno o per forza della sua famiglia, entri improvvisamente in un cortile circondato da quattro alte pareti che risuonano delle grida e frastuono di quasi duecento pazzi o tranquilli o furiosi o epilettici, quali orribili impressioni devono commuovere il suo animo! Molti ne ho veduti farsi l’idea di essere nell’inferno ed è l’idea più naturale che possa occorrere al loro spirito desolato”».
Lo studio termina con le dimissioni del direttore Rossi, nel 1930, in pieno fascismo. Che ruolo ha avuto il regime nella storia del manicomio?
«La fine della grande guerra e l’avvento del fascismo comportarono nel manicomio di
Racconigi una serie di lente trasformazioni che nel medio periodo avrebbero condotto l’istituto a cambiare volto. Il regime, dopo le impietose relazioni delle commissioni di vigilanza che avevano portato alla luce una realtà al limite del disumano, voleva dare un’immagine diversa dell’istituto, meno lugubre e più scientifica ed efficiente. Più in generale era la psichiatria dell’epoca a essere investita da quest’ansia di rinnovamento che a Racconigi si concretizzò nel divieto di usare il termine di “manicomio” per sostituirlo con quello di “ospedale psichiatrico” e nell’avvio di una stagione di sperimentazioni e aperture alle novità dell’epoca. Peccato che queste fossero innovazioni come le “terapie shock” che, fondamentalmente, avevano il fine di ridurre la pericolosità sociale dell’alienato attraverso la riduzione degli impulsi pericolosi e, quindi, della vita cognitiva».
Studiare le vicende di un’“istituzione totale” come un manicomio nel corso dei decenni può fornire un punto di vista peculiare sulla storia. Cosa impariamo dal caso di Racconigi?
«La vicenda di Racconigi, soprattutto per il periodo che precede il secondo conflitto mondiale, è pressoché sconosciuta e questo nonostante l’istituto abbia avuto nella geografia psichiatrica del suo tempo un’importanza non secondaria. Per esempio, alla fine dell’Ottocento nell’istituto vennero portati avanti una serie di esperimenti che per il periodo erano assolutamente innovativi, oltre che non accettati da tutta la comunità scientifica dell’epoca. Più in generale la storia di Racconigi ci parla di un’istituzione che per oltre un secolo ha svolto il ruolo di “contenitore” per tutti quei soggetti con cui la società non voleva avere a che fare. E lo ha fatto escludendoli dalla vista dei più e separandoli attraverso le alte mura perimetrali. Eppure allontanare dalla vista i “matti” non ha risolto il problema della follia, né ha disinnescato la possibilità della malattia mentale che, in una certa misura, riguarda tutti, almeno potenzialmente. Ha, invece, soltanto generato ingiustizia, dolore e oblio. Ciò che di sicuro dovremmo imparare dallo studio del caso racconigese è che l’esclusione non è mai la soluzione dei problemi, anche se spesso sembra la strada più facile da percorrere. Seppure io sia molto scettico in proposito, spero che da questa conoscenza di un passato così vicino e tanto tragico derivi una maggiore consapevolezza di cosa significhi mettere in atto logiche di esclusione nei confronti degli ultimi. Sarebbe il modo migliore per onorare la memoria dei tanti alienati dimenticati di Racconigi».
Alto contrasto 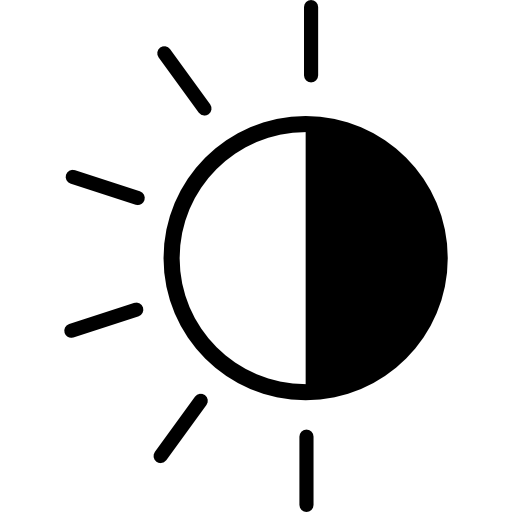 |
Aumenta dimensione carattere
|
Aumenta dimensione carattere  |
Leggi il testo dell'articolo
|
Leggi il testo dell'articolo 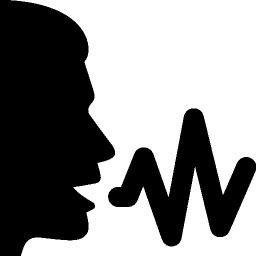
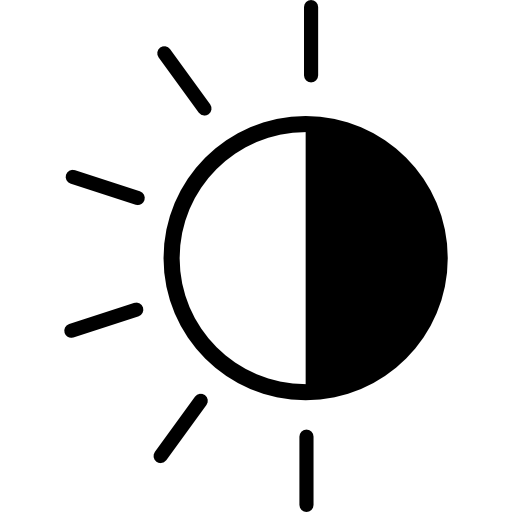 |
Aumenta dimensione carattere
|
Aumenta dimensione carattere  |
Leggi il testo dell'articolo
|
Leggi il testo dell'articolo