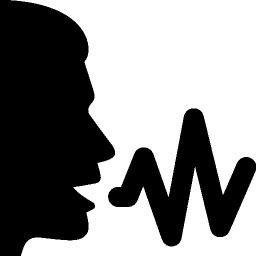L’amore per i cavalli e un lutto familiare che ne ha segnato il percorso umano e professionale. Sono queste le due ragioni che legano Francesco Repice, inconfondibile voce di Radio Rai, dal 1996 radiocronista delle principali partite del calcio italiano e internazionale, alla provincia di Cuneo. Dalle origini cosentine al trasferimento a Roma, fino al rapporto profondo con la Granda, dove lo zio Rocco perse la vita come partigiano il 26 novembre 1944: nella sua biografia c’è uno spaccato importante dell’Italia repubblicana, che traspare con prepotenza e passione dalle sue parole. Quella stessa Italia che dal 2014 lo fa urlare, come radiocronista ufficiale della Nazionale, e a cui ha indissolubilmente legato il suo nome con il racconto della trionfale vittoria azzurra a Wembley lo scorso 11 luglio.
Repice, partiamo dal suo rapporto con Cuneo, nato a causa della tragica morte di suo zio Rocco. Si è informato sulla vicenda?
«Molto, anzi, credo di conoscere quasi tutto quel che è possibile sapere. Zio Rocco era il primo di nove fratelli, in un’epoca in cui il primogenito era visto con grande ammirazione in famiglia. In casa, era il solo a potersi permettere una camicia pulita. Erano anni di povertà ma anche di felicità. Chi si alzava per primo trovava qualcosa per colazione, e non era solo un modo di dire. A Tropea, dove vivevano i miei nonni, era chiamato “il principe dei gagà”, perché era bello e affascinante. La mia infanzia è stata segnata dal suo mito».
Una vicenda che, quindi, è rimasta a lungo nei ricordi della sua famiglia…
«Penso che sia sufficiente dire che i miei nonni, due umili lavoratori calabresi, non si ripresero mai e morirono nei primi anni Sessanta, profondamente addolorati da quella tragedia. So per certo che, a guerra finita, mia nonna ricevette i vestiti che zio Rocco indossava nel momento della fucilazione. Fu, di fatto, l’ultimo ricordo materiale di un uomo che aveva scelto la via partigiana come risposta a un regime che non condivideva e come forma di legittimazione nei confronti di parenti e familiari che, da un giorno all’altro, lo avevano visto abbandonare la divisa dell’esercito fascista».
Pur non avendolo conosciuto, quanto le ha lasciato?
«Il suo ricordo ci ha accompagnati per anni. Un giorno, negli anni Settanta, mentre guardavamo la trasmissione televisiva “Sapere”, vidi mio padre sobbalzare sul divano e urlare “Rocco!”: era certo di avere visto suo fratello in alcune immagini sulla Resistenza nelle valli cuneesi. Ho richiesto a lungo quei filmati a Rai Teche, ma non è stato possibile ritrovarli».
È mai stato a Cuneo nel luogo dove venne ucciso suo zio?
«Sembrerà incredibile, ma non ci sono ancora stato. So che esiste una lapide commemorativa e che si trova nei pressi della stazione, ma non ho ancora avuto modo. E pensare che in provincia di Cuneo mi ha già portato la mia passione per i cavalli…».
Ce ne parli…
«Sono già stato a Termine, frazione di Villafalletto, dove c’è l’azienda di Claudio Risso, uno dei migliori maneggi che io conosca. Appena il lavoro me lo consentirà nuovamente tornerò e mi sono già ripromesso di fare tappa anche a Cuneo per ricordare zio Rocco».
Quali emozioni pensa le susciterà la lapide?
«È un luogo della memoria, che dice tanto della nostra Italia. La presenza di quella e molte altre lapidi sparse in tutta la Penisola è il modo migliore per confermare come questo Paese, che qualcuno ha cercato di dividere in passato, sia in realtà indivisibile. Quando vengo al Nord, negli occhi di un qualsiasi contadino cuneese vedo lo stesso vissuto di un pescatore della mia Calabria: questa è l’Italia per cui hanno perso la vita zio Rocco e tanti altri giovani pieni di ideali».
A proposito di ideali, su WhatsApp, come immagine personale, lei ha scelto un collage dei volti di Che Guevara e Maradona. Che cosa rappresentano?
«Sono due facce della stessa medaglia, con il loro essere eccezionali, ma anche con i loro limiti. Sono due argentini che hanno scelto di mettere in pratica ciò che sentivano nel cuore e nella mente, anche a costo di correre dei rischi. Il “Che” ha perso la vita per degli ideali, mentre Maradona ha fatto più politica con i suoi piedi e, a carriera finita, con le sue dichiarazioni, di molti politici del mondo».
Prima di diventare radiocronista, è stato a lungo “cronista di palazzo”. Se lo fosse oggi, che cosa direbbe di questa Italia?
«Direi che è importante considerare il concetto di “democrazie giovani”. L’Italia, che è democrazia dal 1946, rientra in questa categoria e, come tale, deve ancora stabilizzarsi. Le ferite del passato non sono ancora del tutto rimarginate ed è importante che chi ha coscienza di quel che è stato ricordi a tutti che si deve continuare a lavorare per l’unità d’intenti».
Le manca il lavoro da cronista parlamentare?
«No, anche perché ho lottato a lungo per diventare radiocronista sportivo. Dirò una cosa controcorrente: un giornalista sportivo può occuparsi della “cronaca di palazzo”, perché la mastica quotidianamente quando si confronta con le vicende politiche, economiche e sociali che influenzano lo sport, mentre non tutti i “cronisti di palazzo” sarebbero in grado di parlare di sport».
La sua radiocronaca dei rigori di Italia-Inghilterra, che hanno regalato il titolo europeo agli azzurri, è stata ascoltata più del commento televisivo. Se l’aspettava?
«Se dicessi di no, non sarei sincero. Anche se non ero fisicamente a Wembley (perché a casa in isolamento fiduciario, ndr), ho vissuto la partita da tifoso. So che qualcuno dei vecchi maestri delle radiocronache potrà non apprezzare, ma io sono fatto così. Per me, senza enfasi, una cronaca non ha lo stesso valore».
Ma ci dica la verità: si era preparato le parole da pronunciare in caso di vittoria?
«Assolutamente no! Anzi, stupirò a dirlo, ma in cabina di commento non porto né appunti né tanto meno una penna. La radiocronaca è pura emozione, mista a memoria storica. Il tifoso vuole sapere dov’è il pallone, non essere riempito di statistiche e dati inutili».









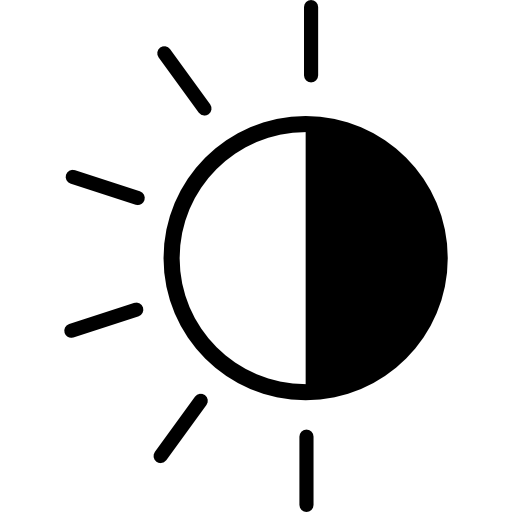 |
|
 |
|