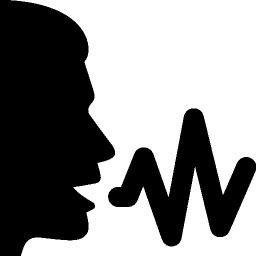Raccontando di una vita vissuta ci si può fare ingabbiare dalla nostalgia o dal rimpianto oppure si possono ricreare le vicende rimettendo in scena tutti i tasselli con la stessa energia di un tempo e ricostruendo i dettagli in maniera così nitida che all’ascoltatore sembrerà di essere stato al cinema. Cesare Giaccone, storico oste dal respiro internazionale ma con Albaretto Torre nel cuore, racconta la sua vita da “chef” controcorrente riportando sul set le albe del mercato dei tartufi a Ceva, le scorribande per l’Italia con la Delta integrale e le grida all’asta del pesce di Savona. Ma per il gran finale torna sempre alla sua Langa, madre e nutrice generosa quanto selettiva, che non si accontenta di una gita domenicale per lasciarsi scoprire. «La Langa non è per tutti», mette in guardia Cesare «perché questa terra bisogna capirla».
Cesare, lei si definisce un “anarchico langhetto”. Non sono due concetti opposti?
«Anarchico lo sono stato fin da bambino, con i miei amici facevamo esplodere le bombe di acetilene dopo averle nascoste nel terreno. Non volevamo mica ammazzare nessuno, erano degli esperimenti. Sono langhetto perché della mia terra ho ricordi indelebili a partire dalla bottega di mio padre: accanto c’era la stalla con una mula, una vacca e una capra da cui mi mungevo il latte».
Dal latte munto in stalla ai manicaretti che proponeva nel suo ristorante la strada è lunga. Da dove è iniziata?
«Forse la prima scintilla è scoccata a nove anni quando andavo in bicicletta con mia sorella a vendere saponette, schiuma da barba e lucido da scarpe nelle cascine intorno al paese. Lei guidava e io spingevo. Le famiglie a volte ci invitavano a restare a mangiare con loro e, anche se mia madre si raccomandava sempre di non assaggiare niente, la nostra fame era da lupi e così ci accomodavamo. Quando vai a casa di qualcuno e assaggi un cibo nuovo è sempre qualcosa di intimo. Apparecchiavano con una bella tovaglia ricamata mentre a casa mia si mangiava alla buona, con patate e zucche cotte in ogni modo. Il mio palato si è formato a quelle tavole imbandite con “tajarin”, pollo, agnello, qualche volta cacciagione, acciughe e, se capitavi il giorno giusto, perfino il pesce…
Quando è passato dall’avere un buon palato al voler diventare cuoco?
«A sedici anni lavoravo come “furic”, aiuto muratore, ero svelto, mi arrampicavo sui tetti come un gatto. Aurelio Scavino, un grande chef dell’epoca, guardandomi all’opera mi disse “sei veloce, potresti fare il cuoco”. Mia madre era cuoca e la vedevo faticare e friggere per ore i pezzi del fritto misto, così risposi che no, quella vita io non la volevo fare. Scavino non si perse d’animo: “Ma io ti faccio girare il mondo: ti porto ad Aosta, dove ci sono gli stambecchi”. Quella promessa di viaggi in posti esotici non la potevo rifiutare, anche se io gli stambecchi non sapevo bene cosa fossero. Mia madre la prese male, come quando anni prima le avevo confidato che volevo diventare frate. Alla fine convinsi mia nonna che mi fece cucire delle giacche da cuoco e iniziai l’avventura»
Un aspirante frate che diventa chef di un ristorante tra i più ambìti della zona. Che ricordi ha di quegli anni?
«Venivano in tanti, negli anni ’70 e ’80 soprattutto, i dirigenti di grandi aziende come Ferrero e Fiat se trovavano tutto occupato, si preparavano il tavolo da soli e aspettavano. Io riempivo una “cavagna” di tume, salami e una bottiglia di vino per ingannare il tempo. Siccome non avevo il telefono, per prenotare chiamavano al numero di una maestra del paese che poi correva ad avvisarmi: “arrivano da Torino”. Una volta arrivò senza preavviso un gruppo di alti papaveri tra cui un giornalista di Tribuna politica, il produttore Bruno Giacosa e Romano Levi della distilleria. Il ristorante era così al completo che dalla stalla di un mio vicino tirammo fuori dei balòt di paglia e li coprimmo con delle belle tovaglie ricamate a mano. Riuscimmo a farli accomodare tutti e ad arrangiare un pranzo memorabile».
Quale piatto in particolare rendeva questi pranzi memorabili?
«Il risotto ai quattro formaggi. Sceglievo il riso Carnaroli migliore, una buona tuma, la fontina, altri formaggi locali e il parmigiano. Sedici minuti ed era pronto, il risotto va mangiato al dente. Io portavo la pentola in mezzo al tavolo e alla fine facevano a gara a ripulirla con il pane, allora pensavo “ma sarò bravo così?”».
Qualche sbaglio l’avrà pure commesso…
«Tanti. Ma quando andavo a dormire riflettevo “oggi ho fatto questo errore, domani provo a fare meglio”. Ripensavo al menù, quel bollito un po’ troppo cotto, quelle carote troppo crude. Le critiche erano preziose, sembrava me ne fregassi invece nel buio aggiustavo i conti con me stesso tutte le sere».
Una ricetta nata per caso?
«Le patate alla grappa. Volevo dedicare una ricetta a Romano Levi, il “grappaiolo angelico”, ma non mi veniva l’ispirazione. Un giorno ho provato a mettere delle patate nel forno, senza sbucciarle e lavarle. Quando sono uscite, belle morbide, le ho tagliate a metà e le ho bagnate con una spruzzata di grappa Levi a quaranta gradi. Una bomba! Ancora sporche di terra bruciata, sistemate su un vassoio con qualche foglia colorata, le patate alla grappa sono diventate il mio aperitivo».
Com’era Romano Levi?
«Eccezionale. Di poche parole, ma con un’intelligenza acuta. Aveva sofferto da piccolo per questo era legatissimo alla sorella. Veniva spesso da me per gustare il risotto ai quattro formaggi. Quando andavo a Neive, nella sua distilleria, era tutta un’avventura; era affezionato ai ragni e alle formiche, non si potevano calpestare, quando passavano dovevi alzare i piedi e dare la precedenza. Lui era molto amico di Bruno Giacosa così discorrevamo spesso di vino e di cucina, come si fa qua in Langa. Si parlava di tutto e di niente, come si fa tra veri amici».
Ma che cosa è questa Langa?
«La Langa non è per tutti, anzi è per pochi perché bisogna avere la pazienza di capirla, è lei che ci insegna. Nella mia vita ho piantato milioni di alberi, erano piccole piantine che sistemavo con la zappa ora passeggiando vedo alberi enormi. Quando gli passo accanto sento solo pace e l’albero inizia a conversare con me, con la terra, con il silenzio. Non serve alcuno sforzo, basta che si muovano le foglie e la natura ti ha già detto tutto. I nostri boschi ci regalano l’ossigeno che ci manca, in tutti i sensi. Basta essere pronti ad ascoltare, la Langa non ama tanta confusione».
Un suo piatto da acquolina in bocca?
“Le acciughe fritte. Specialmente verso luglio, hanno un sapore incredibile».
A proposito di sapori incredibili, un piatto di cui è orgoglioso?
«Le cipolle ripiene a modo mio. Infilavo le cipolle con il sale nel forno e poi, dopo averle svuotate, le riempivo di besciamella e parmigiano che andavo a prendere a Reggio Emilia. Ho sempre tenuto una ruota di scorta di Parmigiano, quando la spaccavo mandava un profumo che durava una settimana».
Quale piatto, invece, la coccola quando è triste?
«Il semolino dolce, che ho imparato a preparare da una nonna di novant’anni, è un ottimo rimedio contro il cattivo umore».
In un’intervista ha detto «la cucina aggiusta le guerre, le amicizie, l’amore». In che senso?
«Mangiare bene e conversare sono il segreto di una vita felice. I contadini un tempo si spaccavano la schiena, ma passavano ore a discorrere tra di loro. Io non ho il computer, non mi sono mai abituato al telefono, ma ho buoni amici con cui chiacchierare. Ho sempre parlato solo un “bel piemunteis” ma mi sono fatto capire in tutti i Paesi».
Qualcuno a cui dire grazie?
«Per primo al cuoco Aurelio Scavino che mi ha trovato. E ai miei clienti che mi hanno voluto bene e mi hanno detto sempre la verità, perché grazie alle loro critiche sono migliorato. E un grazie enorme a questa Langa. Non riuscirò mai a ricambiare quello che mi ha dato la mia terra: mi ha insegnato così tanto che poi io con una patata e una cipolla ho conquistato il mondo. Il mio pezzo di mondo».









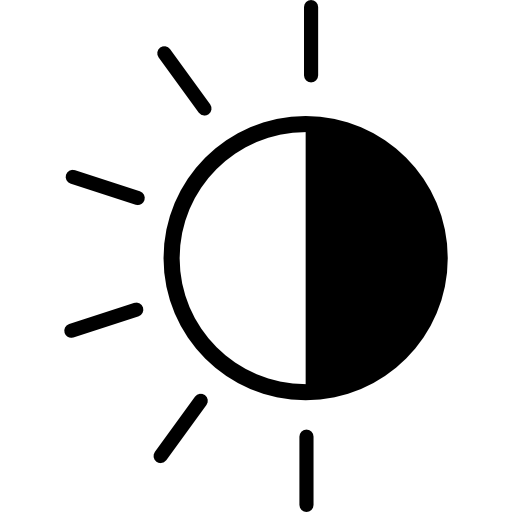 |
|
 |
|