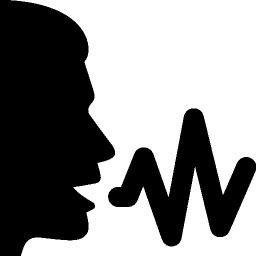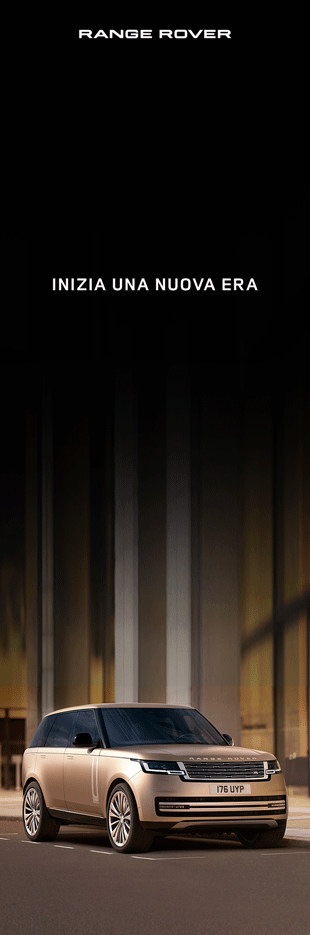Gli orizzonti che osserviamo sono parecchio confusi: in atto c’è, infatti, un processo di cambiamento destinato a mutare definitivamente la proiezione nel futuro di noi stessi e del mondo che ci circonda. Un contesto che obbliga ciascuno a tratteggiare i nuovi scenari, specie gli imprenditori che sono chiamati ad attuare un autentico ripensamento strategico. Da dove partire? Lo spiega bene nel suo nuovo libro – “Cambiamente”, in uscita domani, venerdì 30, con Hoepli – Giovanni Siri, affermato professore milanese di Psicologia, esperto di processi di cultural change e di megatrend, con all’attivo numerosi progetti di comunicazione d’impresa che lo hanno portato anche a collaborare ad Alba, con la Ferrero ed Egea. Lo abbiamo intervistato.
Giovanni Siri, da dove parte la sua analisi?
«Da un bisogno personale, senile direi, vista la mia età, di tirare le fila e cercare di trasmettere qualcosa di quello che ho appreso nel corso della vita. Da vecchio boomer, colgo il cambiamento in atto. Quando ero giovane davanti a me e a quelli della mia età c’era una società tutta da costruire. Oggi ciascuno tende a rifugiarsi nell’“io speriamo che me la cavo”, nella soggettività o nel “non ci posso fare niente”. È un atteggiamento legittimo, ma alla lunga se non ci si prende cura collettivamente della nave su cui si naviga, il rischio è di affondare. È quello che sta accadendo alla Terra, con la nostra specie che potrebbe addirittura estinguersi, seppure tra moltissimo tempo».
È una conseguenza della modernità?
«La modernità ci ha dato tantissimo e ciò che ci ha dato dobbiamo custodirlo con cura. Penso al benessere, al metodo scientifico, alla visione organizzativa, alla razionalità, all’idea di libertà, all’individualismo nella sua accezione più positiva. Tutto ciò è però costato un certo prezzo: è stato giusto pagarlo, ma ora bisogna prendere coscienza delle conseguenze che questa situazione ha determinato».
Ci faccia un esempio.
«Prendiamo il caso delle aziende, specie le più grandi. Prima i dipendenti venivano quasi considerati come macchine o robot; ora, grazie al benessere figlio della modernità, non accettano più di essere trattati in quel modo. Si sentono più consapevoli dei propri diritti e della loro autorealizzazione, della loro socialità, che sono peraltro in grado di comunicare. Bisogna tenerne conto e non fare l’errore che spesso compiono i genitori, ovvero di continuare a vedere i propri figli come dei bambini anche quando in realtà sono già adolescenti».
Che tipo di mutazione stiamo vivendo?
«Stiamo vivendo un cambiamento complesso e irreversibile. Dobbiamo smettere di pensare che prima o poi tutto tornerà come prima. Questa tempesta ci condurrà necessariamente su un’altra sponda. È inevitabile per tante ragioni: i mutamenti climatici, le migrazioni, la riorganizzazione dei sistemi produttivi, l’intelligenza artificiale, l’affermazione delle singole generazioni, i cambiamenti di geopolitica. E poi conta molto il fatto che noi occidentali siamo profondamente cambiati sul piano della personalità, dei desideri, del modo di intendere la nostra vita con gli altri e con il lavoro».
Cos’è il lavoro oggi?
«Le generazioni Z vogliono che nessun momento della loro vita vada perduto e, pertanto, intendono il lavoro come un ulteriore strumento per far fiorire la loro vita. E il guadagno, da solo, non basta. Non hanno un progetto chiaro per il loro futuro – e, del resto, come potrebbero averlo considerando il contesto che li circonda – ma vogliono essere liberi e sanno che il vero valore è la loro stessa vita, la loro esperienza».
Le conseguenze della fase di cambiamento in atto?
«L’esito del processo in corso non è prevedibile e ciò ci getta nell’incertezza. Incertezza che, a sua volta, provoca insicurezza. Questo perché siamo ormai abituati a controllare praticamente ogni aspetto della nostra vita: dall’agenda degli appuntamenti alle previsioni del tempo. E poi si teme che i mutamenti possano minare il livello di benessere raggiunto. Così ora è come se avessimo la vista annebbiata, con il rischio di non riuscire a mettere bene a fuoco il cambiamento in atto e le strade per percorrerlo».
Lei cosa propone?
«Di cambiare occhiali, di indossare lenti in grado di farci vedere i limiti con cui guardiamo le cose. Sembra un’azione banale, ma non lo è affatto. Anzi, si rischia una paralisi generale. Le aziende, però, non possono permetterselo. Chi fa impresa è obbligato ad andare avanti e confrontarsi con la realtà avendo uno sguardo di scenario e un piano strategico. Dunque, il consiglio è di guardare in faccia il cambiamento, studiarlo e poi definire una strategia».
Su quali valori deve basarsi tale strategia?
«Il modello di riferimento, in questo senso, può essere quello delle industrie piemontesi, ma il ragionamento potrebbe essere chiaramente esteso ad altre realtà imprenditoriali italiane particolarmente virtuose. Penso in particolare a molte aziende medio-grandi che, nonostante la loro crescita, non hanno mai perso contatto con il territorio sul quale sono radicate e nemmeno con le persone che lo abitano, mostrando sensibilità umana e visione elastica. La chiave, quindi, soprattutto per gli imprenditori, è avere consapevolezza del cambiamento in atto, dei propri limiti ma anche del fatto di avere a disposizione delle risorse su cui puntare. Come ad esempio il legame con il territorio e il valore del lavoro, da intendersi come uno strumento capace di far sentire le persone vitali e gratificate».
«Alle imprese dico più strategia e radici solide»
Il professor Siri e il suo legame con l’albese: «qui la risposta»










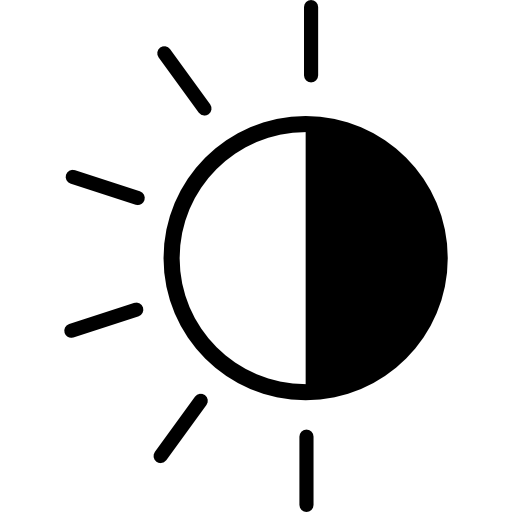 |
|
 |
|